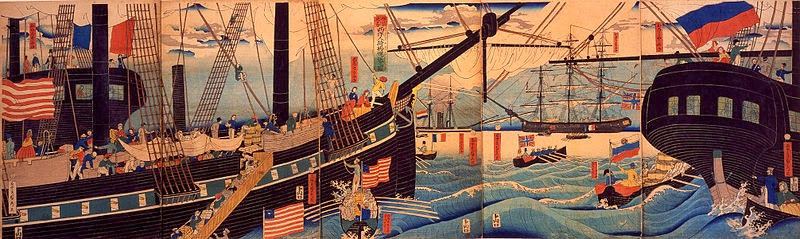Racconto scritto questo
Natale, vagamente allegorico. Come fonte dominante, c'è il
capolavoro, molto sopravvalutato a mio avviso, di Neil Gailman,
American Gods. E conseguentemente, uno dei Tropes che più amo, cioè
All Myths Are True. Stupido, ma divertente. Da quanto ricordo, con
Gailman gli dei si fermano a Internet, rappresentata-
banalissimamente, e in modo parecchio retrogrado- come un bambino grasso e disadattato. Vabbè.
Ho pensato di portare
questo concetto avanti, e trasporre lo status di divinità ai social
network stessi. Dopotutto, nell'era attuale, non è raro trovare
gente che considera la visita giornaliera a Faccialibro ai pari di
una preghiera, o che avverte una sincera perdita di fede, quando
salta la connessione internet. E già trascuro gli hipster che
fotografano ogni cosa che si muove, o gli evangelisti twitteriani,
impegnati in feroci crociate contro gli araldi del bianco&blu.
Non è questo, "un
mondo che ha perso la fede".
Come sempre, se vi va
commentate! Nella mia intenzione, i due differenti piani – prima
persona maschile e terza persona femminile di Aletheia - in cui si
svolge la vicenda avrebbero dovuto intersecarsi con maggiore
chiarezza, ma come ho constatato dal silenzio dei forum di scrittura,
in effetti la gente fatica a comprendere cos'ho scritto. Non forse
sul piano dell'intelligibilità- fortunatamente! - quanto piuttosto
nel fine stesso della vicenda. Il fatto stesso che abbia considerato
necessario questo breve preambolo, è un segno che manca chiarezza
nel racconto. ^.^
Aletheia
(1/2)
Sospiro, mentre tazza di
caffè nella sinistra e mano destra sul mouse, aguzzo gli occhi sulle
nuove notifiche. I punticini rossi brillano sullo schermo blu.
Clicco, clicco frenetico: assaporo con sogghigno sulle labbra la
replica irata di un bimbetto caduto nella mia provocazione da troll,
osservo con distaccato disinteresse la risposta negativa di un cesso
con cui ci stavo provando e termino infine, postando un frammento di
Heidegger, che a essere ben sincero non comprendo, ma che ah! Lì
sulla bacheca mi trasforma presto, nell'intellettuale impegnato che
vorrei sembrare.
Sbatto le palpebre,
stropiccio l'occhio arrossato. Sono cinque ore, che chatto online.
Cinque ore che batto sulla tastiera, mando email, e di tanto in
tanto, compilo distratto gli appunti della nuova lezione che dovrei
andare a preparare. La schiena arde al contatto con il cuoio nero
della poltrona, le braccia dolgono. La mano destra? Metastasi del
tunnel carpale. Sono stanco, ma non riesco... non riesco a smettere.
C'è un pensiero che mi tormenta. Dalla pausa in cui bevevo il thè
del primo pomeriggio, e guardavo distratto le gru del porto
ondeggiare alle raffiche della tempesta a venire. Non è la prima
volta che mi sovviene un'idea; e non è certo novità che l'idea in
questione appaia come un lavoro geniale, un progetto fantastico,
"qualcosa di mai visto prima". Ma nel caso in questione era
diverso. Non avevo la chiara sensazione di scrivere il solito,
delirante frankenstein d'idee rubate, storpiate, torturate per farle
sembrare qualcosa di mio. Stavolta, per la prima volta dopo anni e
anni sentivo che un pensiero nuovo aveva fatto capolino. Timido,
sbirciava dietro l'angolo. Un po' come il gatto della mia vicina,
sempre tanto riluttante alla carezza. O come quelle ragazze che non
riesci mai a invitare da nessuna parte, perchè non appena parli, già
le vedi indietreggiare, sparire dietro lo scaffale dell'ennesima
biblioteca. E così l'ho persa quest'idea, questo pensiero nuovo e
autentico. Impegnato in mille altre cose, ho lasciato che si
smarrisse nei meandri della mia mente. Tolgo lentamente le cuffie,
barcollo con le giunture che gridano vendetta alla finestra. Respiro
l'aria carica di pioggia, che picchia in strada in uno scrosciante
diluvio. Un'idea, un pensiero di libertà. Mi afferro la fronte fra
pollice e indice. Chino il capo. La mia piccola creatura. Perduta!
Aletheia scivola per le
dune di sabbia rovente, affonda i sandali in passi faticosi. Impreca,
quando superato l'ennesimo dislivello, scruta l'orizzonte vuoto. Il
gioco di un dio beffardo, quel mondo. Una distesa desolata di sassi e
sabbia. Non una pianta, non un animale. Inclina il capo a fissare il
cielo assolato, di un azzurro stinto, divorato da un globo infuocato
che risulterebbe riduttivo, definire "sole". Apre le labbra
screpolate. Invoca l'acqua, la pioggia. " E già che ci siamo,
il mare, e pronta una cazzo di galea a salvarmi! " Chiude gli
occhi, li riapre. " Stupida, stupida, stupida! " Si batte
il pugno sul peplo, affonda le mani nella sabbia. Pietre.
Sbriciolate, arse, trasformate in finissima polvere dorata.
" Dove sono? Dove
cazzo sono? " Ricorda ancora le verdi distese dell'Olimpo, la
folla di dei, semidei, eroi. A giocare, guerreggiare, schernirsi. Da
Zeus ad Atena, alle muse e ai satiri. E poi loro, le mezze cartucce.
Gli aborti. Non titani adorati da popolazioni festanti, o dei a cui
massacrare cento e cento vergini. Gli dei feccia. Dionisio. Le Graie,
le Erinni, le Muse. E poi lei, Aletheia! Nemmeno un dio, nel senso
pieno del termine. Ma una parola, un segno. Un'idea nella testolina
di un filosofo troppo occupato a pensare. " Siamo scarti "
constata Aletheia. Relitti nel folle percorso della ragione. Gli
scarti nelle guerre di generazioni e generazioni di filosofi. Difesi
da eserciti di critiche e trattati, innalzati all'ultima soluzione,
all'ultima verità. Solo per subire l'oltraggio di troppi
rivoluzionari, troppi allievi che superano il maestro, troppa
destructio spinta al suo spasimo. Non esiste Aletheia. Non esiste
verità ultima.
- Nasconditi!
Nasconditi, sciocca! -
Una voce sottile,
stridula. Aletheia alza il viso, inquadra la sottile silhouette di un
airone in volo. L'uccello veleggia verso di lei, si ferma a
mezz'aria, sbattendo le ali dai mille colori. Aletheia alza un
sopracciglio, perplessa.
- Thot? Il dio della
scrittura? Che ci fai...-
- Che ci faccio qui? –
Gracchia, socchiude il becco affilato. Con gesto di nauseante autocompiacimento, s'appollaiola sulla spalla di Aletheia, che a
stento si regge in piedi al peso gigante dell'airone.
- Sai – La dea
stringe i denti, impreca – non sei proprio un leggero
pappagallo...-
- E tu non sei solo
un'umana sperduta, mia cara. Sei lo scarto della mente di un
filosofo, quindi taci e ascolta chi è più vecchio, di te, chiaro?
-
- Egizi, greci... Siamo
più o meno lì, no? -
Thot chioccia una risata
maligna. - Eravamo vecchi quando voi greci ancora vi massacravate con
clave e pietre, Aletheia. - L'airone le strofina il becco nero sulla
guancia, avvicina l'affilatissima punta all'occhio nero di Aletheia,
che sbatte frenetica le palpebre. - Non provocarmi, puttanella -
La dea deglutisce amaro.
Azzarda qualche nuovo passo sulla duna in salita. Scivola nella
sabbia bollente.
- Parlavi di un
pericolo...- Sospira – non è che sapresti dove sono, per le palle
di Zeus? -
- Huhu – sibila Thot.
- Una così dolce boccuccia che pronuncia parole tanto volgari! -
- Non lo sai, nemmeno
tu, vero? - Sogghigna Aletheia. - Sei anche tu intrappolato in
questo... Inferno! -
- Err...- Thot
gracchia, stringe gli artigli nel soffice peplo bianco di Aletheia.
La ragazza resiste strenuamente all'impulso di grattarsi la spalla,
dove macchie di sangue ormai macchiano il tessuto. - No! Va bene,
non lo so! - il dio della scrittura sbatte le ali, schiaffeggia
Aletheia. - Mi avrà intrappolato l'ennesimo scribacchino disperato,
o il solito ragazzino appassionato di piramidi! -
- Quindi... Vorresti
dire che siamo nella mente di un umano? Ma com'è...-
- Forse sì, forse no.
Cioè, non lo so, Seth si fotta: non lo so! - Thot apre e chiude il
becco, ticchetta frenetico – Può essere che siamo solo
emanazioni, doppi, tripli della nostra autentica identità. Magari
in quest'esatto momento, la vera Aletheia pasteggia nell'Olimpo,
mentre la sua ombra bestemmia nel deserto. Chissà! Ma quanto conta,
è che non siamo soli! -
- Altri dei? Come noi?
Ma se...-
- Erano tre cavalieri,
Aletheia. Ma ignoro se siano davvero dei, o cacciatori di questo
deserto maledetto. Si muovono lenti, goffi. Gesticolano parolacce,
grugniscono. Sono come infanti, bambini che non sanno ancora
controllarsi. Ma possono fare male, se non stai attenta – Thot
alza un'ala, espone una lacerazione fra le piume, un buco della
forma di un cerchio perfetto, gocciolante inchiostro. - Hanno
bastoni che tuonano, i bastardi -
- Ma siamo dei, no? Non
possiamo morire? -
- E Afrodite, ferita al
polso da Diomede, nella vostra ridicola guerra di Troia? E Ade,
trafitto da una freccia di Eracle? Possibile che debba essere io, a
ricordartelo? Ferire un dio, mutilarlo... E' sempre possibile. -